 Il
fiume proseguiva nella pianura la linea difensiva dell'altro sacro baluardo: il
Monte Grappa.
Il
fiume proseguiva nella pianura la linea difensiva dell'altro sacro baluardo: il
Monte Grappa.
...il Piave comandò “Indietro va’ straniero”!
Freddo, pioggia, fango: compagni di due anni di guerra del Fante italiano. Ma in queste giornate di Novembre 1917, era lo scoraggiamento che annebbiava tutte le sofferenze. Le scarpe bagnate intirizzivano i piedi stanchi dal lungo camminare, ma l'immagine di paesi natali lasciati in mano al nemico ghiacciava il cuore! Quasi si dimenticava la tragedia del Carso, mentre stanchi ed abbattuti si traversavano i ponti sul Piave. Il Piave: ultimo baluardo opposto all'incalzare nemico. Su questi argini si dovevano difendere i valori più importanti. Sarebbe stato possibile?
Verso le prime ore del pomeriggio del 9 novembre 1917 alcune forti esplosioni segnalarono la distruzione dei ponti sul fiume; poche ore di tregua da quel tragico inseguimento che era cominciato nelle valli ad est di Cividale e che aveva coinvolto nella tragedia la 2a e la 3a Armata.
"Noi siamo inflessibilmente decisi: sulle nuove posizioni raggiunte, dal Piave allo Stelvio, si difende l'onore e la vita d'Italia. Sappia ogni combattente qual'è il grido e il comando che viene dalla coscienza di tutto il popolo italiano: morire, non ripiegare". Questa la ferrea, ultima consegna di Cadorna. Nello stesso giorno in cui portava il suo Esercito sulle posizioni di difesa, destando elogi dai Comandi nemici, il Comandante Supremo pagava, in buona parte ingiustamente, la disfatta dei giorni precedenti
 Il
fiume proseguiva nella pianura la linea difensiva dell'altro sacro baluardo: il
Monte Grappa.
Il
fiume proseguiva nella pianura la linea difensiva dell'altro sacro baluardo: il
Monte Grappa.
Un rapido sguardo alla cartina rende immediatamente chiara la visione di cosa rappresentasse questa nuova linea difensiva. Circa 200 chilometri più corta, si costituiva appoggiandosi a due valide difese naturali: dietro era la fine!
Toccò principalmente alla gloriosa 3a Armata ed ai resti dell'infelice 2a Armata quest'arretramento che coinvolgeva fiumane di civili che, con poche masserizie, abbandonavano i paesi natii!
Strade intasate da colonne di soldati e di civili, depositi incendiati, paesi abbandonati dove si udivano fragorosi scoppi che demolivano materiale non trasportabile rendevano lo scenario degno delle bolgie dantesche. Ma lo scoraggiamento era il dato più impressionante: notizie in parte infondate, unite alla iniziale mancanza di ordini e direttive opprimevano l'animo di soldati che non conoscevano la vera situazione e non potevano intuire il loro futuro.
Ma
il crollo degli alti Comandi concesse libertà di azione ai Comandanti in
sottordine, quelli più direttamente a contatto con i soldati. E fu questa una
delle cause fondamentali del cambiamento che, in quella tragedia, si realizzò
in un Esercito apparentemente annientato.
Il 27 ottobre comincia il ripiegamento che impone ai resti della 2a Armata una sosta al fiume Torre ed al Tagliamento per proteggere la ritirata della 3a Armata, unico residuo totalmente efficiente dello schieramento.Il 1 novembre le due Armate sono schierate sul Tagliamento dove si impone una sosta per il riordino dei Reparti in previsione dell'ultima tappa verso il Piave. Il 10 novembre trova l'Esercito Italiano sul nuovo fronte. Tralasciando la situazione della 1a Armata, non coinvolta nello sfondamento, sulla linea Grappa-Piave sono dislocati 300.000 uomini (altri 300.000, sbandati, sono in vari campi di concentramento nella pianura retrostante). Fra gli Alleati, ed alcuni esperti italiani, si nutrono seri dubbi sulla capacità di reggere all'urto e si prevede un ulteriore arretramento. Ma tali previsioni saranno smentite dal valore del Soldato Italiano!
Da solo, riacquistata in breve tempo la forza d'animo e la capacità difensiva, il nostro Soldato sosterrà ul nuovo urto della truppe nemiche, fermandole in quella che a ragione sarà definita "la battaglia d'arresto".
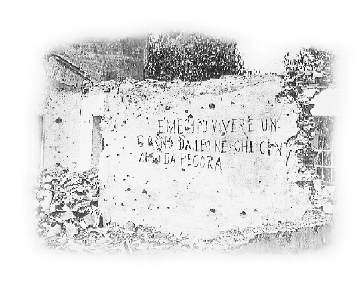 Sul
Piave sono schierate 13 Divisioni Italiane a fronte delle 27 austrotedesche.
Numerosi i tentativi nemici di sfondare la linea italiana, ma quasi tutti sono
respinti con tenacia e sacrifici. Il Fiume si comincia a colorare del sangue
della riscossa. Sono accorsi sul fronte anche i richiamati della classe 1899,
giovani appena diciottenni che si integrano splendidamente con i reduci di
anni di guerra. Solo presso Zenson e a Grisolera il nemico riesce a stabilire
piccole teste di ponte al di qua del Fiume. A Fagarè, un'iniziale avanzata
austriaca viene rintuzzata, dopo aspri combattimenti fino al 17 novembre, e i
nemici sono costretti a riattraversare le acque gelide del Piave. L'epicentro
degli scontri, ii Molino della Sega, farà palpitare in quei giorni gli animi
dei combattenti, ma il successo della resistenza convincerà i soldati della
solidità della linea Grappa-Piave: la speranza si riaccende!
Sul
Piave sono schierate 13 Divisioni Italiane a fronte delle 27 austrotedesche.
Numerosi i tentativi nemici di sfondare la linea italiana, ma quasi tutti sono
respinti con tenacia e sacrifici. Il Fiume si comincia a colorare del sangue
della riscossa. Sono accorsi sul fronte anche i richiamati della classe 1899,
giovani appena diciottenni che si integrano splendidamente con i reduci di
anni di guerra. Solo presso Zenson e a Grisolera il nemico riesce a stabilire
piccole teste di ponte al di qua del Fiume. A Fagarè, un'iniziale avanzata
austriaca viene rintuzzata, dopo aspri combattimenti fino al 17 novembre, e i
nemici sono costretti a riattraversare le acque gelide del Piave. L'epicentro
degli scontri, ii Molino della Sega, farà palpitare in quei giorni gli animi
dei combattenti, ma il successo della resistenza convincerà i soldati della
solidità della linea Grappa-Piave: la speranza si riaccende!
Nel mese di Dicembre si consolidano le difese in attesa del balzo in avanti. Il 9 gli austriaci occupano la testa di ponte italiana di Capo Sile che viene riconquistata la notte successiva; negli ultimi giorni dell'anno, viene abbandonata la testa di ponte di Zenson. Il Fiume e tutto italiano ed il 1917 si chiude con la completa riabilitazione dell'Esercito Italiano dopo le oscure e tragiche giornate di Caporetto.
La primavera del 1918 trova entrambi gli Eserciti attivi in scaramucce ed apprestamenti offensivo-difensivi. É nel giugno che gli Austriaci, perso l'apporto delle truppe tedesche lanciano l'offensiva che ritengono "definitiva".
Il
15 giugno tutto il fronte, dallo Stelvio al Mare è coinvolto in questo poderoso
attacco. Subito stroncato sul fronte della 1 Armata, lo scontro si fa duro e
cruento sugli Altopiani, sul Grappa, sul Montello e sul Piave. Su quest'ultimo
fronte si contrappongono due famose Armate: la V Armata austroungarica o
"Isonzo Armee", forte di 14 divisioni e la 3a Armata Italiana
"l'Invitta" con 7 divisioni. Piccoli paesi fino allora sconosciuti
alla massa degli italiani faranno fremere mille cuori e saliranno alla ribalta
della cronaca: Cavazuccherina, San Bartolomeo. Monastier. Anche piccoli isolotti
del corso del Piave acquisteranno un nome che  resterà
anche dopo la guerra come l'"Isola dei Morti". Il Fiume viene superato
dal nemico da Candelù a Capo Sile su una lunghezza di circa 30 chilometri per
una profondità di di 5 chilometri nel punto massimo, ma in questa occasione si
rivelerà un altro fattore positivo del nuovo schieramento: mentre con una certa
facilità potranno accorre i rinforzi italiani, non così si verificherà per le
truppe nemiche che tanto si sono allontanate dai punti di rifornimento. La
veloce avanzata non era stata seguita con altrettanto celerità dalle salmerie.
resterà
anche dopo la guerra come l'"Isola dei Morti". Il Fiume viene superato
dal nemico da Candelù a Capo Sile su una lunghezza di circa 30 chilometri per
una profondità di di 5 chilometri nel punto massimo, ma in questa occasione si
rivelerà un altro fattore positivo del nuovo schieramento: mentre con una certa
facilità potranno accorre i rinforzi italiani, non così si verificherà per le
truppe nemiche che tanto si sono allontanate dai punti di rifornimento. La
veloce avanzata non era stata seguita con altrettanto celerità dalle salmerie.
Nella notte tra il 22 ed il 23 giugno 1918 gli austriaci sono costretti a riattraversare il Fiume sacro. É vinta la "battaglia del Solstizio" e con essa, praticamente la guerra e non soltanto sul fronte italiano.
Il Piave era stato consacrato dal sangue di 41.238 soldati italiani di cui: 2.596 caduti, 12.727 feriti, 25.915 dispersi. Ma con esso si era mescolato quello di 51.900 austroungarici.
Dal 2 al 6 luglio il Comando Supremo decide un'azione per portare la linea italiana dal Piave Vecchio al Piave Nuovo ed allontanare il rischio per Venezia distante appena 23 chilometri. Alle 12 del 6 luglio 1918 l'azione si conclude vittoriosamente
Il 24 ottobre, anniversario di Caporetto l'Esercito Italiano attacca la battaglia definitiva: solo tre giorni più tardi, il Piave permetterà il suo attraversamento che darà inizio alla liberazione dei territori veneti occupati ed alla corsa per la conquista di Trento e Trieste. Il Piave entrerà prepotentemente nei cuori degli italiani per aver mantenuto fede alla parola d'ordine "di qui non si passa"!